Il Padiglione – Architecture of Stewardship
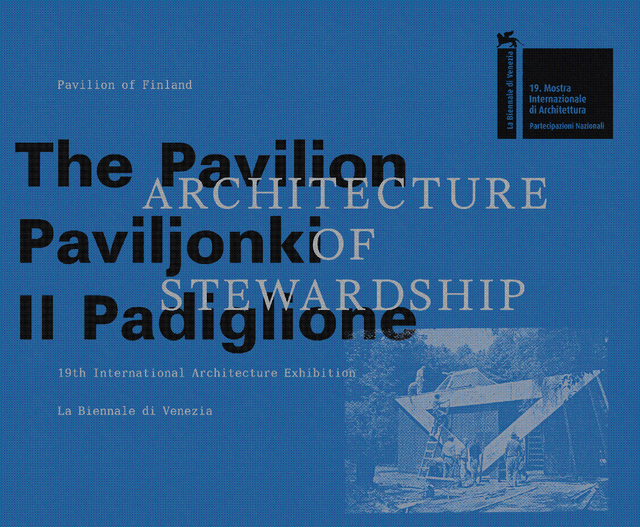
La mostra nel Padiglione della Finlandia alla 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia è curata dagli architetti Ella Kaira e Matti Jänkälä. Qui puoi leggere i contenuti della brochure della mostra in italiano.
L’architettura è spesso vista come la creazione esclusiva dell’architetto o dell’architetta. Si tratta invece di un’impresa collaborativa che si avvale di diverse professionalità: dai contributi progettuali dell’architettura e dell’ingegneristica al lavoro legato all’edilizia, la manutenzione, la pulizia e il restauro, ognuna di queste competenze svolge un ruolo fondamentale nella creazione e la conservazione dell’ambiente costruito.
Il Padiglione della Finlandia ai Giardini della Biennale di Venezia ci invita a ripensare il nostro rapporto all’ambiente costruito e l’attività umana da esso richiesta. Creato dall’architetto Alvar Aalto e dal suo studio, l’edificio sorge in sole due settimane nella primavera del 1956. Progettato come struttura temporanea, viene costruito in legno importato dalla Finlandia, materiale poco adatto al clima umido della laguna veneziana.
Eppure il Padiglione è ancora qui, e la sua sopravvivenza testimonia del costante sforzo investito per proteggerlo dalle intemperie. Senza la cura costante di innumerevoli mani, l’edificio sarebbe da tempo fatiscente, svuotato e in rovina.
Essendo uno dei due edifici progettati dal leggendario modernista Alvar Aalto in Italia – e l'unico ad essere stato completato durante la sua vita – il Padiglione della Finlandia ha una dimensione mitica che ne ha senza dubbio favorito la conservazione, dandogli un certo vantaggio rispetto ad altri edifici che, non avendo lo stesso prestigio, sono condannati a un futuro incerto.
La preservazione del patrimonio edile è una questione di stewardship, una pratica senza tempo radicata nella cura e la responsabilità. Nel contesto dell’architettura, la stewardship è un compito condiviso tra una vasta gamma di professionalità che operano una negoziazione tra territorio, risorse e ambiente costruito nel rispetto delle necessità di attori umani e non-umani. La mostra Il Padiglione. Architettura della Stewardship aspira a rendere visibile questa dimensione invisibile.
Il Padiglione – Architettura della Stewardship
La mostra, curata dagli architetti Ella Kaira e Matti Jänkälä, esplora il lavoro necessario per garantire la longevità dell'architettura, chi si assume questa responsabilità e perché sia importante, tracciando l’evoluzione del Padiglione dalla sua costruzione a oggi attraverso decenni di costante manutenzione e tre importanti restauri. Le storie delle persone coinvolte in questo lavoro le identificano come co-creatrici accanto all'architetto originale.
Archinfo, il Centro Informazione per l'Architettura Finlandese, è il commissariato del Padiglione Finlandese alla Biennale Architettura. Archinfo mette in evidenza il valore sociale dell'architettura favorendo uno sviluppo edile che miri a un futuro più sostenibile e promuovendo i valori e le competenze dell’architettura finlandese a livello internazionale.
Installazione audiovisiva
Proiezioni e suoni danno vita ai ricordi racchiusi nelle mura del Padiglione. Merle Karp (videoartista) e Jussi Hertz (sound designer) raccontano la storia del Padiglione finlandese combinando video e foto d’archivio con riprese più recenti, effettuate durante la Biennale d’Arte del 2024 e i lavori di manutenzione del 2025. La narrazione si svolge attraverso audio interviste di persone che hanno contribuito alla storia del Padiglione.
Installazione audiovisiva multicanale, durata 30 minuti
Storia del Padiglione della Finlandia
1955 La Finlandia viene invitata a partecipare alla Biennale dell’anno successivo, dando alla mecenate Maire Gullichsen l’idea di creare un padiglione nazionale. Gullichsen chiede all’amico Alvar Aalto di progettare una struttura espositiva temporanea.
1956 Viene deciso di collocare il padiglione temporaneo della Finlandia di fronte a quello dell’Ungheria, rimasto vuoto e in rovina in seguito alla Rivoluzione Ungherese.
1956 Il Padiglione viene costruito e inaugura la sua prima mostra, dedicata al lavoro dell’artista Helene Schjerfbeck, alla 28° edizione della Biennale d’Arte.
1962 In seguito all’inaugurazione del Padiglione dei Paesi Nordici, quello finlandese viene riutilizzato come deposito dall’organizzazione della Biennale.
1968 Nel corso di manifestazioni a Venezia e ai Giardini, alcuni padiglioni vengono occupati dai manifestanti.
1968 Il Padiglione della Finlandia è affittato all’Argentina fino alla Biennale d’Arte del 1972.
1976 Primo restauro del Padiglione a cura dell’architetto danese Fredrik Fogh, in seguito alla morte di Alvar Aalto.
1976 Dopo il colpo di Stato in Argentina, il Padiglione della Finlandia viene affittato al Portogallo.
1980 Prima Biennale di Architettura.
1984 L’Islanda prende in affitto il Padiglione della Finlandia per le sue partecipazioni alla Biennale d’Arte fino al 2005.
1988 Corrado Pedrocco inizia a lavorare come addetto alla manutenzione per i Padiglioni della Finlandia e dei Paesi Nordici.
1990 Timo Keinänen è nominato alla supervisione del Padiglione per conto del Museo dell’Architettura Finlandese.
1991 Electa pubblica il libro Alvar Aalto: The Finnish Pavilion at the Venice Biennale, a cura di Timo Keinänen.
1991 La gestione del Padiglione è trasferita allo Stato Finlandese.
1993 Restauro a cura del Professore e architetto finlandese Panu Kaila.
1994 Panu Kaila supervisiona il lavoro dei carpentieri italiani nella seconda fase del restauro.
1994 Il copyright sul Padiglione della Finlandia decade in seguito alla morte di Elissa Aalto, che lo deteneva dopo Alvar Aalto.
2006 Senaatti-kiinteistöt, l'ente statale finlandese responsabile della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, nomina Hannu Hellman come responsabile del Padiglione.
2006 L’architetta Mia Kuokkanen è nominata responsabile della manutenzione del Padiglione, posizione che manterrà fino al 2011.
2007 La Finlandia riprende la gestione del Padiglione per la Biennale d’Arte al posto dell’Islanda.
2010 Sotto la supervisione di Jorma Lehtinen, il Programma di Conservazione dell’Università Metropolia di Scienze Applicate provvede a ridipingere le pareti esterne del Padiglione.
2011 Un albero cade sul Padiglione.
2012 Gianni Talamini dirige il restauro del Padiglione e assume il ruolo di architetto addetto alla manutenzione fino al 2014.
2014 Stefano Ferro è nominato architetto addetto alla manutenzione del Padiglione.
2016 Tekbe srl installa i pannelli che coprono i lucernari, su progetto di Stefano Ferro.
2018 La Perla srl riveste le pareti interne del Padiglione con pannelli protettivi in Okoumé, su progetto di Stefano Ferro.
2020 Vita Restauri ridipinge le pareti esterne del Padiglione per la 17o Biennale di Architettura, ma in seguito allo scoppio della pandemia globale di COVID-19 l’inaugurazione è rimandata prima ad agosto 2020, poi a maggio 2021.
2022 Vita Restauri reintroduce lo “spazio di commissario” su progetto di Stefano Ferro. Nel contesto della mostra di Pilvi Takala per la Biennale d’Arte, il Padiglione viene dotato di un sentiero in pietra sul retro e di un’unità di climatizzazione.
2024 Co.me.s. srl installa una rampa di ingresso accessibile, su progetto di Stefano Ferro.
2025 In occasione della prossima mostra, il rivestimento in tela delle pareti interne viene rimosso, lasciando i pannelli a vista. Le pareti interne ed esterne del Padiglione vengono ridipinte e il pavimento restaurato.
L’insegna della Finlandia
Alcuni dettagli del Padiglione sono stati realizzati in loco nel 1956 dallo stesso Alvar Aalto, che ha accuratamente ritagliato in cartone le lettere dell’insegna, perfezionandone la misura prima che l’artigiano Viljo Hirvonen le ricreasse in metallo presso l’officina del vetraio Paolo Venini a Murano. L’insegna potrebbe essere stata inizialmente installata per mascherare un cavo elettrico.

La betulla
Durante il restauro del 2012, l’architetto Gianni Talamini decide di piantare una betulla per simboleggiare il legame con la Finlandia. L'albero cresce sul prato accanto al Padiglione Centrale senza essere notato dai giardinieri. Purtroppo l'albero viene abbattuto durante la pausa del 2024-2025, forse a causa del restauro del Padiglione Centrale o di una malattia fungina. Tuttavia, il ceppo dell’albero è ancora al suo posto.

Le lastre di ingresso
In origine, il dislivello tra il sentiero e l'ingresso del Padiglione era segnato da tre lastre in pietra d'Istria di 220 x 120 cm che rendevano difficile l'accesso alle persone con difficoltà motorie. Nel 2024, l'ingresso del Padiglione è stato dotato di una rampa accessibile progettata dall'architetto Stefano Ferro e realizzata da Co.me.s. srl.
Le porte in mogano
Il finanziamento del progetto del Padiglione si è rivelato un sfida fin dall’inizio, spingendo Maire Gullichsen a cercare il sostegno di aziende finlandesi. Una di queste, Wärtsilä, dona al Padiglione le porte originali in mogano. Durante il primo importante restauro del 1976, esse sono sostituite con porte asimmetriche in larice dipinte di blu, progettate dall’architetto Fredrik Fogh. Le maniglie originali di Aalto, da tempo perdute, vengono ricreate in Finlandia dall’artigiano Viljo Hirvonen, che aveva prodotto gli stampi originali.. Durante il restauro del 1993, diretto da Panu Kaila, l’ingresso viene rimodellato e riavvicinato al modello originale, eliminando le modifiche introdotte da Fogh.

Gli elementi “temporanei”
Nel 2022 il Padiglione viene dotato di condizionatore per mantenere costantemente fresco lo spazio espositivo, trasformato in scatola nera. Il Padiglione era inizialmente progettato per essere ventilato in maniera naturale dalla corrente che passa tra le porte sul fronte e sul retro dell’edificio. Tuttavia, come osservato da Gianni Talamini, il Padiglione ha dovuto adattarsi alla crescente richiesta di spazi bui per le installazioni audiovisive.
La mostra del 2022 vede anche l’introduzione di un sentiero esterno in lastre di pietra intorno al Padiglione, che conduce dall'ingresso alla porta posteriore. Sia il condizionatore che il sentiero, introdotti come elementi temporanei, saranno incorporati in tutti i progetti espositivi futuri. Questi elementi sono così di fatto diventati permanenti, rispecchiando la storia del Padiglione.

I triangoli bianchi
La facciata del Padiglione è caratterizzata dalla presenza di grandi triangoli bianchi, descritti da Alvar Aalto come elementi funzionali destinati a tenere insieme la struttura leggera, come “corde avvolte attorno a un pacco.” Tuttavia, l’elemento metallico che avrebbe dovuto fissare i triangoli è rimasto allentato, causando un sovraccarico della struttura. I triangoli sono quindi diventati elementi decorativi anziché supporti strutturali. Nel 1993 i tre elementi triangolari, ricostruiti in larice nel 1976, sono stati sostituiti utilizzando legno di pino proveniente da Kuusamo, nel nord della Finlandia.
Gli emisferi
Negli anni ’90, Corrado Pedrocco, che da tempo lavorava alla manutenzione del Padiglione, ha notato che gli emisferi metallici attaccati agli elementi triangolari assomigliavano a qualcosa di familiare: le calotte rotonde dei pulsanti di scarico del water, all’epoca onnipresenti in Italia. Siccome queste calotte erano esattamente della stessa dimensione, Pedrocco le ha usate per sostituire gli emisferi mancanti o rotti. La manutenzione, dopotutto, richiede improvvisazione e la ricerca di soluzioni sul campo.
L’albero crollato
Il 7 ottobre 2011, Venezia è colpita da una tempesta che fa crollare la grande robinia che sorgeva accanto al Padiglione, distruggendo il tetto e deformando l'intera struttura dell'edificio in legno. L’interno dell'albero, probabilmente scavato da insetti xilofagi, stava marcendo da anni. Dopo settimane di tempeste autunnali e forti venti di scirocco, l'albero, che aveva messo radici molto prima della costruzione del Padiglione, finisce per cedere. Il ceppo dell'albero si trova ancora accanto al sentiero sul lato nord del Padiglione.

I lucernari
Il progetto del Padiglione prende forma rapidamente all’inizio del 1956 grazie a settimane di intenso lavoro da parte dello studio di Alvar Aalto. Come spiegato da Elissa Aalto, “data la superficie limitata dell’area espositiva, nessuna parte delle pareti poteva essere sacrificata all’illuminazione: serviva tutta per le mostre.” Questa necessità ha determinato lo sviluppo di un progetto non convenzionale per il tetto, in seguito criticato da Göran Schildt: “Aalto non aveva considerato i grandi alberi che ombreggiavano il padiglione.” Di conseguenza, filtrava solo una luce verde diffusa che, secondo alcuni critici, conferiva all’ambiente l’aspetto di una “caverna sottomarina.” I lucernari sono diventati uno degli elementi più caratteristici del Padiglione, influenzando anche i successivi progetti dello studio di Aalto.
L’evoluzione delle esigenze di illuminazione per le mostre ha richiesto la creazione di un sistema ad hoc per chiudere i lucernari mantenendo intatte le caratteristiche architettoniche originarie. Progettato dall'architetto Stefano Ferro, il sistema di pannelli per i lucernari è stato realizzato da Tekbe srl nel 2016.
Il patio
Il percorso si sviluppa dall'ingresso attraverso lo spazio espositivo fino alla porta sul retro e al patio. Nel corso dei decenni, l’ambiente intorno al Padiglione, compreso il patio, è cambiato significativamente. Inizialmente, Il Padiglione sorgeva direttamente su un letto di sabbia bianca. Nel 1976 vengono aggiunti un sistema di drenaggio, una fascia di vegetazione lungo le pareti e delle mattonelle in cotto posate tra la vegetazione e la sabbia. Nel 1993, questi elementi vengono rimossi, ripristinando l’iniziale sentiero di sabbia.
Il semplice patio, pavimentato con pietra calcarea e inizialmente concepito per ospitare un piccolo insieme di tavoli, viene modificato nel 1976 con l'aggiunta di panche in pietra d’Istria e una fontana, che in seguito causerà danni da umidità. Questi elementi vengono rimossi negli anni 2010, riavvicinando la spazio alla configurazione originaria.
Gli organismi viventi
Nel 2024, i sorveglianti hanno scoperto che la vite che cresceva lungo la facciata si era introdotta all’interno della struttura, un’ulteriore testimonianza del fatto che il Padiglione non ospita solo creature umane. Inoltre, una colonia di formiche si è insediata nella parete esposta a nord. Durante l'estate, è possibile trovare un grande numero di queste creature all'interno dello spazio espositivo (con grande fastidio degli addetti alla sorveglianza).
Il Padiglione ospita anche molti altri insetti, come i tonchi presenti nella struttura fin dal 1993.
Il fatto di permettere alla vegetazione di crescere nel patio è un modo di riconoscere e riflettere sull’autonomia della natura. Nei paesaggi antropogenici, la stewardship non deve essere un modo di controllare il mondo non-umano ma di creare uno spazio che permetta alla natura di rigenerarsi. Questo concetto ci sfida a considerare ontologie diverse dalla nostra e mette in evidenza l’autonomia della vita non-umana, che prospera e si sviluppa in direzioni che spesso non corrispondono agli interessi umani. Sotto la pavimentazione del Padiglione, tra la vegetazione che lo circonda e lungo il sentiero emergono così sorprendenti forme di vita.

Salinizzazione del pavimenti
Nonostante il Padiglione fosse inizialmente concepito come una struttura temporanea, le fondamenta in cemento sono già presenti nei disegni esecutivi del 1956. La lastra di cemento è stata posata direttamente al suolo senza una ventilazione e impermeabilizzazione adeguate. In combinazione con il fenomeno della risalita capillare, molto diffuso a Venezia, questa configurazione consente all’umidità di risalire attraverso le fondamenta. In condizioni di clima caldo, l’umidità evapora, lasciando sul pavimento dei cristalli di sale durante l’estate. Se non trattato, questo fenomeno può creare gravi danni strutturali.
Le persone del Padiglione
Valentina Albonico & Daniele Canato
Restauratori della ditta Vita Restauri, hanno lavorato alla manutenzione del Padiglione da dicembre 2024 a febbraio 2025.
Arianna
Addetta alle pulizie del Padiglione della Finlandia da quattro anni, con decenni di esperienza lavorativa per la Biennale.
Elisa Da Tos & Ross Hamilton
Addetti alla sorveglianza dei Padiglioni della Finlandia e dei Paesi Nordici, sono stati i primi testimoni della caduta dell’albero sul Padiglione nel 2011.
Stefano Ferro
Architetto addetto alla manutenzione del Padiglione della Finlandia dal 2014.
Hannu Hellman
Coordinatore espositivo e responsabile del Padiglione della Finlandia per conto del Museo dell'Architettura Finlandese dal 1996 al 2006. Responsabile tecnico per conto di Senaatti-kiinteistöt, l'ente statale finlandese responsabile della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, dal 2006 al 2012.
Panu Kaila
Architetto e Professore Emerito, alla guida il restauro del 1993–1994.
Timo Keinänen
Archivista del Museo dell’Architettura Finlandese dal 1990 al 2011, autore del libro Alvar Aalto: The Finnish Pavilion at the Venice Biennale (Electa, 1991).
Mia Kuokkanen
Architetta addetta alla manutenzione del Padiglione della Finlandia dal 2006 al 2011.
Jorma Lehtinen
Architetto e insegnante presso il Programma di Conservazione dell’Università Metropolia di Scienze Applicate, responsabile dei lavori di pittura dei muri esterni nel 2010.
Maaria Mustakallio
Sorvegliante espositiva del Padiglione Finlandese per la Biennale d’Arte del 2024.
Juha Niemelä
Ingegnere responsabile del Padiglione dal 2011 al 2016 per conto di Senaatti-kiinteistöt, l'ente statale finlandese responsabile della gestione del patrimonio immobiliare pubblico.
Corrado Pedrocco
Addetto alla manutenzione dal 1988 al 2020, responsabile dei Padiglioni della Finlandia e dei Paesi Nordici.
Tuula Pöyhiä
Architetta senior presso la Fondazione Alvar Aalto dal 2009 al 2018 e rappresentante della Fondazione per il restauro del Padiglione del 2012.
Gianni Talamini
Architetto responsabile del restauro del 2012 e architetto addetto alla manutenzione del Padiglione dal 2012 al 2014.
Timo Vikkula
Responsabile espositivo presso il Museo dell'Architettura Finlandese (oggi Architecture & Design Museum Helsinki) dal 2002, e in precedenza, dal 1984, assistente coinvolto nell'allestimento di varie mostre di architettura per i Padiglioni della Finlandia e dei Paesi Nordici.
Curatori:
Ella Kaira & Matti Jänkälä
Artista video:
Merle Karp
Progettista del suono:
Jussi Hertz
Progetto di allestimento:
Antti Auvinen
Designer grafico:
Samuli Saarinen
Organizzatore:
Archinfo – Centro Informazione per l'Architettura Finlandese
Commissaria:
Katarina Siltavuori
Archinfo Team:
Miina Jutila, Ulla Kallakivi, Francesco Raccanelli, Anna Rusi
Produzione della mostra:
Rebiennale, Q Studio
Collaboratori:
Gianni Talamini, Panu Kaila, Stefano Ferro
Nuovo materiale video:
Emanuele Basso, Matti Jänkälä, Ella Kaira, Merle Karp
Materiale video di archivio:
Gianni Talamini, Illume Ltd (Venetian Etude 1993, Directed by Jouko Aaltonen & Tellervo Savela, Cinematography by Pertti Veijalainen), Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETSOperaio ETS
Fotografie e documenti:
Gianni Talamini, Stefano Ferro, Alvar Aalto Foundation, Villa Mairea Archive, The National Archives of Finland, Architecture & Design Museum Helsinki, USDA APHIS PPQ / Cesar Calderon Pathology Collection, Rodrigo Cruz Choappa, Michael R Francisco, Kathie Hodge, Maximilian Paradiz, Marc Perkins, Joe Rubin, Marc Rubin
Ringraziamenti:
Asin Pavimenti, Attiva Servizi, Rebiennale, Vita Restauri; Valentina Albonico, Daniela Almansi, Arianna, Emanuele Basso, Daniele Canato, Ross Hamilton, Hannu Hellman, Timo Keinänen, Mia Kuokkanen, Jorma Lehtinen, Maaria Mustakallio, Juha Niemelä, Corrado Pedrocco, Tuula Pöyhiä, Elisa Da Tos, Timo Vikkula
Assistenti alla mostra:
Iines Hakari, Jenni Halme, Suvi Heinonen, Jesse Kauppinen, Saku Koutaniemi, Emma Niskanen, Teemu Parviainen, Salla Sinisammal, Valma Sol
Supervisore degli assistenti:
Tamara Andruszkiewicz, Venice Art Logistics
Sostenitore principale:
Ministero dell’Istruzione e della Cultura della Finlandia
Sostenitore:
Finnish Cultural Foundation
Sponsor principale:
Kontio
Sponsor:
Tervakoski Ltd, Helsinki Distilling Company, Ambasciata di Finlandia a Roma, Artek